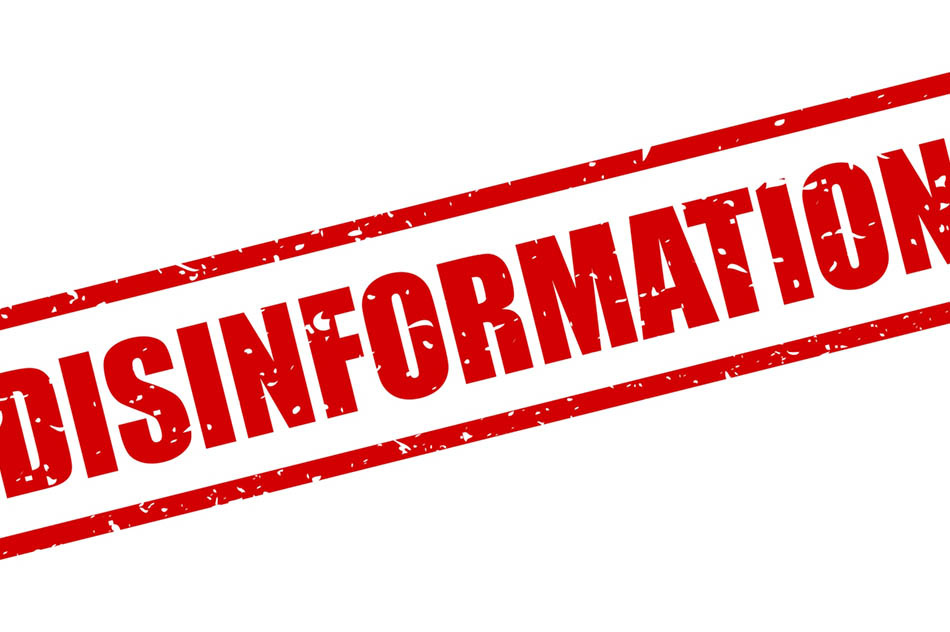«Quello della disinformazione non è certo un concetto dell'epoca contemporanea. Totalmente attuale è però il fenomeno della disinformazione così com’è esploso negli ultimi anni con la progressiva diffusione dell'utilizzo di internet e poi dei social network». Così osserva Antonella Vicini, giornalista professionista e coautrice, insieme a Walter Quattrociocchi di Misinformation. Guida alla società dell'informazione e della credulità (2016), Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità (2018), e Polarizzazioni. Informazioni, opinioni e altri demoni nell'infosfera (2023). Il 9 aprile 2025, Vicini è stata protagonista del seminario “Disinformazione e polarizzazione: Quali rischi per l’Europa”, tenutosi in Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’ambito del Modulo “Jean Monnet” EU Media Freedom, durante il quale la giornalista ha dialogato con Andrea Santini, Luca Gino Castellin e Monica Spatti. Al termine dell’incontro abbiamo rivolto alcune domande ad Antonella Vicini per aiutarci a comprendere il fenomeno della disinformazione.
Che cos’è la disinformazione?
Quello della disinformazione non è certo un concetto dell'epoca contemporanea. Totalmente attuale è però il fenomeno della disinformazione così com’è esploso negli ultimi anni con la progressiva diffusione dell'utilizzo di internet e poi dei social network. Nel 2013 il World Economic Forum ha inserito la disinformazione nella lista delle minacce globali. Per disinformazione, in linea generale, si intende la diffusione intenzionale di notizie o informazioni inesatte o distorte allo scopo di influenzare le azioni e le scelte di qualcuno; diversa quindi dalla misinformation (o misinformazione in italiano) che è la diffusione di notizie false o non corrette in maniera non intenzionale e, quindi, senza uno scopo preventivo. In questi casi, entrambe le definizioni rientrerebbero nella macrocategoria di fake news, questo sì un termine piuttosto nuovo e legato al fenomeno della disinformazione online. Un neologismo, dunque, che si è diffuso dal 2016, un periodo piuttosto complesso e articolato per la vita politica internazionale (pensiamo alla prima elezione di Donald Trump a capo della Casa Bianca e alla feroce campagna elettorale che l'ha preceduta e al referendum sulla Brexit in UK). Non è un caso, dunque, che a dicembre dello stesso anno l’Oxford English Dictionary abbia decretato "post verità" quale parola dell’anno. Ma post truth non è una parola che nasce nell'era dei social. Interessante notare – come ricorda sempre l'Oxford Dictionary – che il primo a usarla sulle pagine del magazine statunitense The Nation fu Steve Tesich nel 1992, a commento dell'affair Iran-Contras; questione altamente polarizzante per l'opinione pubblica statunitense dei tempi. Alla dicotomia disinformation/misinformation però si preferisce il termine "infodemia" intesa come "sovrabbondanza di informazioni, sia online che offline" che include tentativi deliberati di diffondere informazioni errate". Questa è la definizione data dall'OMS in occasione della pandemia da Covid 19.
Quali sono i principali strumenti attraverso cui si diffonde?
In un mondo dell'informazione dominata ormai da dinamiche di comunicazione che hanno mutuato i modelli delle piattaforme social (non solo perché tutte le testate hanno un proprio profilo sociale ma anche perché i social network sono spesso utilizzati come fonte a cui attingere informazioni) non esiste un ambiente immune dal pericolo della disinformazione. Ma anche in questo caso è necessario fare una distinzione fra disinformazione intenzionale e non. In quest'ultimo caso, infatti, la disinformazione può essere frutto di imperizia, della troppo velocità nel dare la notizia (e la velocità è un fattore imprescindibile), della mancanza di specializzazione che è presente in molte redazioni, soprattutto web, che impedisce di cogliere sfumature o inesattezze. Detto questo, in linea generale, la disinformazione è veicolata sulle varie piattaforme - dove possono essere presenti bot e account falsi - ma anche dai media generalisti più tradizionali dove si dà spazio a teorie e/o personaggi controversi senza alcun tipo di contraddittorio o di analisi dei fatti (dicasi anche fact checking). In questo scenario, i modelli delle piattaforme social che, ricordiamolo, non nascono con l'intento di informare e che si reggono sulla commercializzazione di prodotti, tendono ad amplificare la polarizzazione e la disinformazione perché premiano in visibilità le notizie più risonanti, eclatanti e potenzialmente meno attente all'esattezza dei contenuti. Gli algoritmi non fanno altro che potenziare e massimizzare queste tendenze favorendo l'accesso ai contenuti che più corrispondono ai gusti e alle tendenze dei fruitori e la creazione di comunità di utenti chiuse al loro interno.
Come le echo chambers, gli algoritmi e il bias di conferma incidono sulla nostra “credulità” verso le notizie?
Come dicevamo, nel complesso mondo del web, gli utenti entrano in contatto con una quantità smisurata di informazioni di ogni tipo. Ce n'è per tutti i gusti. Cosa succede però? Succede che le nostre capacità cognitive non sono infinite e che il cervello lavora per ottimizzare i processi di analisi del mondo in cui ci muoviamo. In questo contesto, si comprende bene il ruolo del confirmation bias (cioè la tendenza cognitiva che porta a cercare la conferma delle proprie idee e posizioni e a sminuire, o a ritenere meno credibile, ciò che si allontana o diverge da ciò che sentiamo) e dell'esposizione selettiva nei confronti delle fonti. Noi cerchiamo, analizziamo, ricordiamo ciò che scegliamo.Gli studi del Center of Data Science and Complexity for Society dell'Università La Sapienza, diretto dal professore Walter Quattrociocchi, dimostrano, fra le varie cose, che gli utenti più attivi sui social consultano al massimo 10 fonti e che gli ambienti social sono caratterizzati dalla presenza di echo chamber cioè comunità omofile composto da utenti che seguono le stesse narrative, che usano un linguaggio comune e che tendono a non confrontarsi con opinioni a contrasto. La Treccani nel 2017 ha inserito "echo chamber" fra i neologismi definendole così: “Nella società contemporanea dei mezzi di comunicazione di massa, caratterizzata da forte interattività, situazione in cui informazioni, idee o credenze più o meno veritiere vengono amplificate da una ripetitiva trasmissione e ritrasmissione all'interno di un ambito omogeneo e chiuso, in cui visioni e interpretazioni divergenti finiscono per non trovare più considerazione”.L'echo chamber è l'anticamera della polarizzazione e della radicalizzazione delle proprie idee. L'interazione tra questi fattori crea un potenziale un circolo vizioso: noi prediligiamo un certo tipo di notizie e di informazioni, gli algoritmi continuano a proporci informazioni in linea con i nostri gusti, ci rinchiudiamo così facilmente in echo chamber dove troviamo conforto e sostegno alle nostre convinzioni. Tutto questo favorisce la diffusione della disinformazione.
Quali soluzioni possiamo mettere in campo per limitare il problema?
Ad oggi non si può parlare di soluzioni, ma di tentativi di trovare la via più adatta per affrontare questo tema che è particolarmente complesso e che tira in ballo molteplici questioni. Quello che è evidente è che, visti i risultati ottenuti finora, proseguire un dibattito basato sul Vero vs Falso significa solo contribuire a polarizzare. Sempre più si parla di prebunking, invece di debunking (cioè il confutare le false informazioni attraverso il fact checking). Intervenire a contrastare la disinformazione una volta che si è diffusa equivale a cercare di svuotare il mare con un cucchiaino. Certamente è importante lavorare sul "prima" e cioè sull'educazione digitale, per comprendere e conoscere limiti e insidie dello strumento pervasivo che usiamo tutti ogni giorno e per responsabilizzare gli utenti anche nella condivisione di news che mirano a creare allarmismo, che usano toni aggressivi, linguaggio polarizzante o che semplicemente sembrano troppo belle o troppo brutte per essere vere. Da parte sua il giornalismo basterebbe che, almeno, si attenesse ai principi base della propria deontologia: verifica delle fonti, pertinenza e rispetto della verità sostanziale dei fatti. In ogni caso si tratta di un percorso in fieri che deve tenere conto che siamo nel mezzo di una trasformazione epocale.
Project 101175844 – EU – MEDIA FREEDOM